 Sandro Campani vive e lavora in un paese dell'Appennino tosco-emiliano, dove è nato nel 1974. Ha pubblicato È dolcissimo non
Sandro Campani vive e lavora in un paese dell'Appennino tosco-emiliano, dove è nato nel 1974. Ha pubblicato È dolcissimo non  appartenerti piú (Playground 2005), Nel paese del Magnano (Italic Pequod 2010) e La terra nera (Rizzoli 2013). Per Einaudi ha pubblicato Il giro del miele (2017), I passi nel bosco (2020) e Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello) (2023).
appartenerti piú (Playground 2005), Nel paese del Magnano (Italic Pequod 2010) e La terra nera (Rizzoli 2013). Per Einaudi ha pubblicato Il giro del miele (2017), I passi nel bosco (2020) e Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello) (2023).
Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello), Einaudi. Questo suo ultimo lavoro si inserisce con coerenza in un percorso letterario che negli anni ha creato un immaginario coeso e compatto, intorno a colline, boschi e valli, luoghi riconoscibili come zona geografica nell’Appennino tosco-emiliano. Una scelta molto contemporanea, di connessione intima (non di posa) tra vita umana e natura. Una relazione che è quanto mai urgente da ripristinare e ristrutturare. Che effetto le fa vedere quanto la natura si stia “ribellando” al rapporto malato che l’uomo ha instaurato con l’ambiente nell’ultimo secolo e nel presente? Il suo percorso letterario potrebbe essere considerato anche un tentativo di “recuperare” un contatto positivo in questo senso?
Non mi viene da pensarla come una ribellione della natura nei confronti dell’uomo. Piuttosto, una conseguenza nefasta dell’azione umana sulla natura. (Una natura che comunque si modifica anche indipendentemente dall’uomo, in tempi molto più lunghi e diversi). È questa specie di gioco di ruolo o d’azzardo basato sulle regole arbitrarie e stabilite culturalmente dell’economia capitalista, che ci fa pensare che siamo in gioco noi e la natura, il nostro sistema o la natura. In realtà, quello che l’uomo sta facendo è mettere a rischio il proprio ambiente vitale, insieme a quello di molte altre specie. A rischiare non è la natura in sé, che continuerà ad esistere in altre forme e si assesterà. L’ha fatto dopo cataclismi immani, quando noi ancora non esistevamo. Magari sarà una forma che non contempla la nostra esistenza.
Ormai sono abituato a svegliarmi, tante mattine, con un senso di angoscia rabbiosa, di impotenza e di peggioramento. So che è sbagliato, perché porta all’inazione. Pensare che non si possa fare niente non serve. Ma come faccio a sperare in chissà quali miglioramenti? Si è deciso che il profitto è l’unico Dio, non ne restano altri a contrastarlo. In quella che è una sconfitta epocale e irrimediabile di qualsiasi alternativa al capitalismo rapace, il disastro ambientale è la prima cosa che mi interessa, dal punto di vista politico.
Fin qui quello che ingenuamente sento, da persona che, come altri, tenta di conciliare un’etica personale con i mille compromessi quotidiani di cui forse non si rende neanche conto.
Quanto alla scrittura, la vedo come un’osservazione, al limite una testimonianza. Non la vedo come la possibilità di un messaggio positivo, che non sia quello dell’amore per le cose e per un lavoro fatto bene.
Raccogliere i funghi. Una pratica forse non così diffusa, che ha una propria nicchia di riferimento, ma di sicuro non viviamo nell’epoca dell’uomo raccoglitore. Eppure, andare per funghi è un mondo. In genere, si tratta di un hobby che si apprende in famiglia: dal nonno, dal papà, dalla zia. E comporta un insieme di conoscenze molto ampio: i luoghi segreti, che nel passato sono stati teatro di epici di ritrovamenti, gli orari e periodi in cui è opportuno dedicarsi alla ricerca, i rituali, le ipotesi sulle buttate, il lessico fungaiolo appunto. Ma soprattutto: le relazioni. Le camminate nel bosco con i familiari; il mitico fungo gigante ritrovato nel tale anno, che si ricorderà per sempre e di cui conserviamo la foto. Tutto questo per dire che un libro come Alzarsi presto parla a tutti, non solo agli appassionati di boschi e funghi. Perché è un testo sulle relazioni umane, sulla condivisione di esperienze. Cosa significa per Sandro Campani il raccogliere funghi? Quali ricordi? Quali relazioni? Come nasce l’idea di scriverne?
Mi ci era voluto uno sforzo notevole per costruire l’impianto romanzesco de I passi nel bosco; penso sia il libro più complesso e maturo che ho fatto, e ha avuto (tra problemi generali ben più gravi), la sorte di uscire esattamente la settimana di marzo 2020 in cui le librerie chiudevano a causa del Covid.
Dopo questo, non avevo tutta questa spinta per rimettermi a costruire un’altra impalcatura del genere. Invece, essendo anche rimasto chiuso in casa per un po’, per quanto nella condizione privilegiata di chi abita in una borgata isolata in collina, avevo una gran voglia di camminare. Quindi questo libro è nato come un riprendere le forze andando a camminare insieme a mio padre, e a mio fratello. In questo testo, composto di storie brevi legate da un filo ben visibile, alcune col passo di un racconto, altre più descrittive, un vero e proprio arco narrativo da romanzo non c’era.
Però quando si scrive si scrive sempre di relazioni. E infatti il centro del libro si è spostato sulla relazione tra me e mio fratello, su cosa vuol dire essere fratelli, avere un gergo comune, dei ricordi comuni, poter risalire con un solo sguardo a un’infanzia in cui era persino difficile pensarsi come due entità distinte.
Dichiarato fin da subito che la persona che dice io in questo libro sono smaccatamente io, senza mascheramenti da autofiction, così come Pietro è smaccatamente mio fratello, e quelli sono i suoi i cani, ho cercato, per quanto potevo, di mettermi nella posizione di un occhio che guarda, più che di un personaggio a mia volta; ed ecco che l’arco narrativo si è rivelato: partire da un uomo poco più che quarantenne, osservato nella pratica del suo lavoro con i cani dentro al bosco (come se mi avessero spedito a fare un reportage) che mano a mano, a ritroso nel tempo, diventa un personaggio, un bambino, e un fratello.
Il rapporto di Pietro con il bosco è il rapporto di lavoro attraverso il quale si guadagna il pane. (Anche per l’altro mio fratello, visto che parte del suo reddito viene dal tagliare la legna). Chi, nella natura, svolge un lavoro pratico (che sia tartufaio, cacciatore, o boscaiolo) nota certe sfumature più di altre, calcola certi spazi: la geografia del bosco cambia a seconda dell’attività che ci si svolge dentro. È bellissimo ogni volta osservare come un lavoro abbia il suo spazio che, pur coincidendo apparentemente con altri spazi, non è lo stesso; le sue parole, le sue scaramanzie, il suo bagaglio di competenze tecniche, visive, sensoriali. È vero, c’è la condivisione di un alfabeto famigliare, una cosa che si tramanda dai genitori ai figli, e insieme alla passione si trasmette un modo di stare al mondo, di porsi dentro le cose. È una forma di educazione, anche.
Finisce che attraverso il bosco si mette in scena quello che da sempre è stato un mio tema – un senso di inadeguatezza, di distacco da colmare. Ho sempre scritto intorno a questo: stavolta ho solo tolto un filtro, quello dei personaggi e dell’imitazione di una voce. Questo libro è stata anche l’occasione per scavare in maniera diretta e profonda in questo tarlo della disappartenenza – che, paradossalmente, è proprio la cosa che mi permette di scrivere: lo sguardo estraniato, che da pratico è diventato estetico, più inadatto a collegarsi alle mani – certificando un distacco dalle cose che proprio grazie alla scrittura cerco di colmare, sapendo già che è impossibile. Però, almeno, posso circoscrivere, riassestare e mettere in ordine il mio mondo.
E se da questo tentativo deriva una poetica, spero tanto che venga attraverso l’osservazione, non dal bisogno di esprimere. Vorrei cancellarmi, quando sono nel bosco. È un punto di equilibrio che non è stabile, ha un prima e un dopo che lo rovina. Ma in quel momento magico di equilibrio, stare nel bosco con un famigliare diventa qualcosa di totale, che ti sospende dal mondo e dalle cose e ti fa sentire nella pienezza di un tutto, come quando sei bambino e giochi e il tempo è sospeso, ed è, credo, la sensazione più bella che io possa provare. È quella che vorrei provare anche nell’attimo prima di morire. Mi conforta e mi riempie di gioia, di comunione con gli altri, accorgermi che quello che scrivo fa dire a delle persone: “Sento questa stessa cosa”. Così mi sembra di essere riuscito a darle voce. È una piccola cosa che però per me è molto importante.
Il bosco, protagonista non nuovo nei romanzi di Sandro Campani, può essere amico e luogo dell’anima, ma anche nemico. Pensiamo, ad esempio, come si trasforma il bosco durante un temporale, diventa buio e minaccioso, si fatica a orientarsi: tutto appare diverso e ostile. Il fungo, alimento e veleno, ci vuole esperienza e conoscenza per raccogliere il commestibile e lasciare a terra quello dannoso. In certi casi l’ambivalenza è tale che alcuni funghi sono commestibili cotti, ma velenosi crudi. O viceversa. Anche la letteratura contiene le proprie ambivalenze, può essere nutrimento, ma anche ossessione. Sandro Campani, che cos’è per lei lo scrivere: ossessione o nutrimento? Ci parli del suo rapporto con l’immaginazione e la scrittura.
Indubbiamente la scrittura è un’ossessione coltivata con fatica e con piacere (e con un senso di dedizione estrema nel momento in cui la pratico). E credo anche che mi sia preziosa perché mentre scrivo accedo a dei livelli di me stesso che quando non scrivo non posso nemmeno immaginare. La maggior parte delle volte poi, quando ne esco, mi rendo conto che le cose che ho scritto sono al di sopra delle mie possibilità, eppure da qualche parte stavano dentro di me, se le ho fatte. Insomma, è una cosa che mi ossessiona in senso bello, mentre ci sono immerso. Nello stesso tempo, però, so che non sono definito dalla scrittura: non posso permettermelo – quello sì sarebbe un veleno – perché la scrittura non è una cosa che sono; è una cosa che faccio e prima o poi smetterò di fare.
Semplicemente, può accadere da un momento all’altro che smettano di visitarmi immaginazioni che mi tengano stregato al punto tale da seguirle per mesi, anni; perciò, meglio allenarsi a relativizzare questa ossessione. Come per i funghi: se li trovi, sei felice. Se non li trovi, impara a non rovinarti la giornata. Non è una questione di pudore o di falsa modestia, o di mettere le mani avanti – svilire l’impegno, non crederci. (Anzi, io mi arrabbio quando leggo un libro, o guardo un film, e mi sembra che chi me lo sta proponendo non ci creda fino in fondo, o addirittura metta in atto dei meccanismi di disinnesco – ironici, o di altro genere – rispetto a al credere profondamente in quello che mi sta dicendo. Mi viene da chiedergli: Perché mi fai sprecare il mio tempo?)
Solo, devo tenere presente che la scrittura smetterà e che io devo essere pronto ad adattarmi al fatto che non faccia più parte della mia vita: è sano coltivare questa prospettiva.
Insieme a questa intervista suggeriremo i suoi libri ai nostri lettori. Le chiediamo in cambio qualche consiglio per gli amici delle Biblioteche Civiche di Padova. Cosa predilige il Sandro Campani lettore e perché?
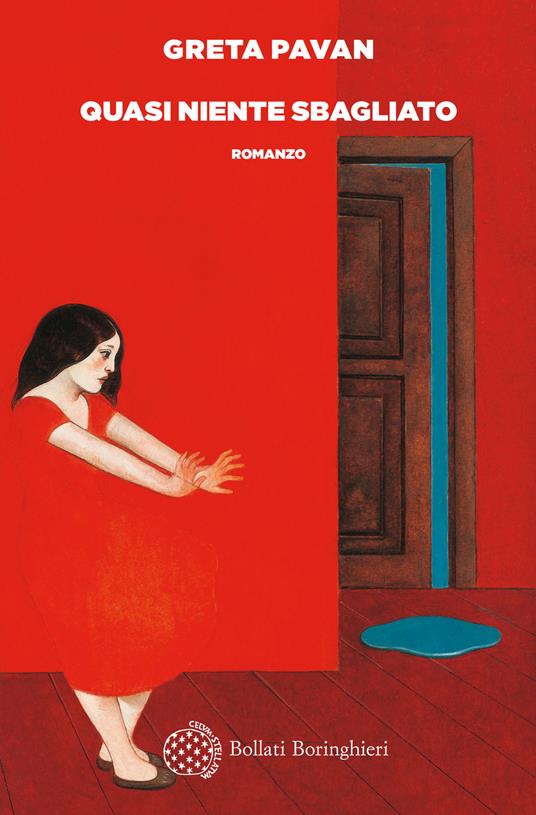 Parto da un esordio, quello di Greta Pavan: Quasi niente sbagliato, Bollati Boringhieri, 2023. In questo libro, che è un romanzo costruito attraverso il montaggio non cronologico di diversi racconti separati, uno per ogni anno della vita della protagonista, Margherita (da quando ha otto anni a quando ne ha ventidue).
Parto da un esordio, quello di Greta Pavan: Quasi niente sbagliato, Bollati Boringhieri, 2023. In questo libro, che è un romanzo costruito attraverso il montaggio non cronologico di diversi racconti separati, uno per ogni anno della vita della protagonista, Margherita (da quando ha otto anni a quando ne ha ventidue).
Fra i vari capitoli memorabili, toccanti e spietatamente umani, veri, che ci sono in questo libro – scritto in una lingua precisa, inventiva, che si prende la responsabilità di rinominare le cose a modo suo – ce n’è uno che narra proprio il momento in cui le cose, fra le mani di questa bambina, smettono il loro essere cose e sfuggono nella trasfigurazione estetica. È l’unico modo che lei trova per salvarsi. È il momento dell’infanzia in cui ci si scopre irrimediabilmente diversi: succede in una soffitta, dove il nonno emigrato veneto in Brianza sta insegnando (più con l’esempio che a parole) al nipote il lavoro della falegnameria. Una scena in cui, in maniera limpida e straziante, Greta Pavan è riuscita a catturare questo baratro che ti si apre all’improvviso nell’infanzia, che ti stacca dalle cose, e ti rendi conto che da quel momento in poi le cose, solamente a guardarle, ti faranno soffrire.
È solo un capitolo fra tanti: alcuni fanno arrabbiare, altri sono lucidissimi nel descrivere la condizione lavorativa, e politica, in cui siamo immersi. C’è uno spaccato descrittivo di una provincia italiana che diventa universale.
Un ladro in caserma, di Tobias Wolff. Tradotto anni fa per Einaudi col titolo Il colpevole, ora lo ristampa Racconti Edizioni. Tobias Wolff per me è uno dei più grandi scrittori degli ultimi quarant’anni, molto meno famoso di quanto meriterebbe. È un grandissimo scrittore di racconti (il suo Proprio quella notte, che uscirà fra poco per Racconti Edizioni dopo essere finito fuori catalogo è, credo, il mio libro di racconti preferito, insieme a quelli di Cechov e di Flannery O'Connor). Un ladro in caserma invece è una novella, o un romanzo breve, di novanta pagine perfette, altezza Dostoevski, in cui si scava nell’animo umano in una maniera micidiale, attraverso una scrittura apparentemente semplice che però ha un grado di profondità inarrivabile. La giovinezza, la paura di non essere come gli altri, l’inadeguatezza alla vita, il Vietnam che aleggia come una fine possibile.
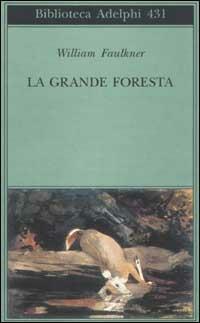 Infine, La grande foresta di William Faulkner: una raccolta di racconti che ha appunto al centro il rapporto degli umani con la natura, nel momento in cui l’industrializzazione arrivava a cambiare per sempre sia il paesaggio che gli uomini che ci vivono dentro. All’interno di questo libro di Faulkner c’è il racconto che è quasi un riassunto del suo mondo epico: ricchissimo, barocco e ubriacante come lui sa essere, e perfetto. Si intitola L’orso. Racconta di una caccia, forse una delle ultime cacce all’orso nella contea che Faulkner ha fatto teatro di tutte le sue storie. E attraverso questa caccia ci dà conto dell’iniziazione di un bambino, di una comunità, ci dà conto di un mondo che scompare e di un altro che si annuncia con il treno che fende la foresta. È una grandissima avventura.
Infine, La grande foresta di William Faulkner: una raccolta di racconti che ha appunto al centro il rapporto degli umani con la natura, nel momento in cui l’industrializzazione arrivava a cambiare per sempre sia il paesaggio che gli uomini che ci vivono dentro. All’interno di questo libro di Faulkner c’è il racconto che è quasi un riassunto del suo mondo epico: ricchissimo, barocco e ubriacante come lui sa essere, e perfetto. Si intitola L’orso. Racconta di una caccia, forse una delle ultime cacce all’orso nella contea che Faulkner ha fatto teatro di tutte le sue storie. E attraverso questa caccia ci dà conto dell’iniziazione di un bambino, di una comunità, ci dà conto di un mondo che scompare e di un altro che si annuncia con il treno che fende la foresta. È una grandissima avventura.
Il residuo di un mondo primigenio, atavico, dove le potenze della natura e le forze che stanno dentro l’animo dell’uomo si scontravano lealmente, e si influenzavano a vicenda. È un racconto crudele, se vogliamo, violento, perché è un racconto di caccia. Ma c’è un grande rispetto, un rispetto animistico potremmo dire, tra i cacciatori che rincorrono la preda, e ogni anno tentano di raggiungerla ingannarla e infine ucciderla, e questo orso gigante, che è un orso immenso, furbissimo, che riesce sempre a sfuggire. Sta nei giochi, che uno sopravviva e uno muoia. Ma c’è un rispetto incrollabile. Perché nel gioco, di cui sei soltanto un piccolo frammento che volerà via in un attimo, la natura continuerà, e ha potenze che ti passano attraverso e sono molto più grandi di te.
La ferrovia taglierà la foresta per secoli in cui la lotta per la vita era andata avanti sempre allo stesso modo. All’arrivo del treno, un orso spaurito scappa sopra un tronco. Non riesce più a scendere da questo tronco, finché alcuni vecchi cacciatori non si siedono a vegliare, affinché nessuno spari all’orso mentre è in condizione di debolezza, aggrappato a questo tronco, e affinché l’orso possa scappare via di nuovo nella foresta.
